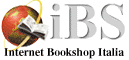
|
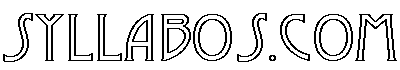 Easing communication
Easing communication
|

|
| 22:41:36 UTC +0000 20-Nov-2025 |
| IL PORTALE LINGUISTICO ITALIANO |
| HOME | ARTICOLI | DIZIONARI ON-LINE | FORUM | LINKS | MERCATINO | PROFESSIONISTI | CHI SIAMO |
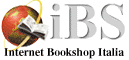
|
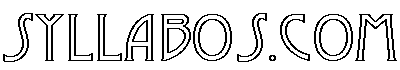 Easing communication
Easing communication
|

|
| 22:41:36 UTC +0000 20-Nov-2025 |
| IL PORTALE LINGUISTICO ITALIANO |
| HOME | ARTICOLI | DIZIONARI ON-LINE | FORUM | LINKS | MERCATINO | PROFESSIONISTI | CHI SIAMO |
|
Università degli Studi di Bologna Tesina
sui Caratteri Cinesi
NǙ
La donna nella Scrittura Cinese di Nicola Nobili La presente dissertazione analizzerà uno dei caratteri maggiormente ricorrenti nella scrittura cinese, ossia il logogramma[1] “donna”, che in cinese si trascrive e si pronuncia “nǚ”. Il carattere è estremamente semplice (figura 1):
Figura
1: il carattere “nǚ” Esso si compone di appena tre tratti: il primo scende verso sinistra, per poi essere ribattuto verso destra a metà altezza (piĕdiăn), il secondo parte da metà altezza e scende da destra a sinistra, intersecando il primo in basso (piĕ), il terzo e ultimo è un semplice tratto orizzontale, a metà altezza, che scorrendo da sinistra verso destra interseca il primo tratto ed il punto iniziale del secondo (héng). Il corretto ordine dei tratti è riportato qui di séguito (figura 2):
Figura
2: l’ordine dei tratti Per disegnare il carattere in maniera corretta occorre immaginarlo all’interno di un quadrato ideale, ed è necessario che vengano rispettati alcuni criteri fondamentali, ossia, per dirla con Abbiati e Chen (1997:44-46), “il tratto orizzontale deve essere piano […] e il baricentro ben equilibrato”, “l’insieme deve risultare compatto e ben proporzionato”, “i tratti debbono apparire animati e dinamici”. Si riporta nella seguente figura 3 un esempio del carattere “nǚ" su carta quadrettata, al fine di evidenziare il corretto andamento dei tratti e di esaltarne l’armoniosità delle proporzioni.
Figura
3: proporzioni del carattere Storia ed evoluzione del carattere Si sta analizzando un carattere estremamente antico, come testimonia la sua stessa natura pittografica: i pittogrammi, ossia caratteri che riproducono graficamente il referente della parola stessa, sono infatti il primo tipo di carattere a comparire; esso si presta unicamente ad esprimere un certo numero di concetti concreti, come nomi di persona, di animale ed alcune entità naturali come il sole, la luna e la montagna (si vedano Abbiati, 1992:170 e Albanese, 1989:47). I pittogrammi, è opportuno precisare, costituiscono un’esigua frazione dell’intero repertorio linguistico cinese. Si pensi che già nel 100 d.C. nel dizionario di Xǔ Shèn solamente il 4% dei caratteri elencati è di natura pittografica (dato estratto dal sito Zhongwen.com), e che da allora, verosimilmente, alcuni di essi sono caduti in disuso o sono divenuti comunque di uso meno comune, visti gli enormi cambiamenti che ha subito la società cinese nel corso dei millenni. Originariamente, nel carattere era possibile identificare una donna nell’atto di prostrarsi, “inginocchiata, con le braccia raccolte nelle maniche” (Yuan, 1993:155; figura 4):
Figura
4: immagine tipo da cui prende spunto il pittogramma L’illustrazione ha generato un pittogramma che, originariamente (3400 anni fa circa), quando veniva inciso sui gusci di tartaruga, aveva l’aspetto che si può vedere nella figura 5[2].
Figura
5: pittogramma originario (1400 a.C. circa) Il disegno mostra chiaramente la postura genuflessa della donna, ritratta di profilo. Nel corso dei secoli, “nǚ" ha subito, come la quasi totalità dei segni del repertorio logografico cinese, alcune modifiche, ma queste non sono state troppo rilevanti: un’occhiata ai disegni riportati nella figura 6, che mostrano, rispettivamente, il carattere “nǚ" nel periodo delle iscrizioni sui bronzi (1100 a.C.), nello Stile del Piccolo Sigillo (200 a.C.), nello Stile Amministrativo (100 a.C.) e nello Stile Esemplare (300 d.C.) dimostra che, a parte lo sviluppo di una maggiore “geometricità” dei tratti, il segno linguistico è rimasto sostanzialmente immutato, al punto da essere facilmente riconoscibile in ogni epoca.
Figura
6: evoluzione nei secoli del carattere nǚ L’unica grafia che si discosta in maniera notevole è quella corsiva (figura 7), ma in questo caso si deve parlare piuttosto di una modalità di scrittura particolare, che esalta la rapidità a discapito della precisione nell’esecuzione, non di una differenza di carattere storico-evolutivo.
Figura
7: stile corsivo nǚ
nei composti
“Nǚ” si incontra nei caratteri composti unicamente in vece di radicale, ossia della parte del carattere che fornisce l’aggancio semantico al nuovo carattere, ma non indicazioni sulla sua pronuncia. Non si utilizza, invece, con funzione fonetica, anche a causa della scarsezza di morfemi cinesi che presentino una notevole somiglianza acustica col carattere in questione[3]. A differenza di molti altri radicali, quando “nǚ” rientra in un carattere complesso non subisce alcuna modificazione grafica di rilievo, limitandosi ad assumere dimensioni leggermente più “schiacciate” per poter occupare assieme ad un altro insieme di tratti lo stesso spazio che occuperebbe da solo. Un carattere di uso così comune e che si riferisce ad un concetto tanto elementare dà luogo, com’è ovvio supporre, ad un gran numero di composti. Il dizionario di Zhao e Gatti (1996) ne riporta 56, il sito Internet Zhongwen, 78, il dizionario di Viotti Bonfanti (1991) ben 174[4]. Assai spesso questi composti presentano il radicale “nǚ” a sinistra e la componente fonetica a destra. In qualche caso (una decina o poco più), la donna viene spostata nella parte bassa del quadrato ipotetico che circoscrive il carattere. A questa regola sembrano esistere solamente due eccezioni assolute. La prima è costituita dal carattere “zhuāng” (“truccarsi”), dove il radicale, che pure sembra perfettamente appropriato dal punto di vista del significato, occupa inspiegabilmente la metà destra del quadrato (figura 8)
Figura
8 il carattere zhuāng La seconda eccezione, più apparente che reale, è data da “wēi” (“potenza”, “forza”), dove la donna, di dimensioni ridotte, si ritrova incastrata nel basso, circondata da altri tratti in tre direzioni (si veda la figura 9). L’anomalia è però, in questo caso, ben facile da spiegare: dovendo combinarsi con un altro elemento piuttosto esteso, che occupa quasi per intero il quadrato immaginario, la componente radicale non ha potuto fare altro che inserirsi nell’unico spazio rimasto libero.
Figura
9 il carattere wēi
Figura
11: l’ideogramma “ān”
Figura
23: l’ideogramma “xìng” Per concludere la rassegna sul carattere “nǚ” si aggiungerà una breve notazione di carattere prettamente grammaticale, che pur non essendo strettamente connessa alla grafia del carattere si ritiene opportuno menzionare per ragioni di completezza. “Nǚ”, pur essendo tecnicamente un sostantivo, viene sovente impiegato con funzione di aggettivo, giustapponendogli un altro carattere di cui svolge il ruolo di determinante. In questa maniera la lingua cinese sopperisce, in qualche modo, alla sua totale assenza di flessioni, che ne è la principale caratteristica morfologica. Si forniscono soltanto due esempi di questo diffusissimo fenomeno (Figura 25). Nel primo, aggiungendo “nǚ” alla sinistra del carattere “wáng”, cioè “re”, otteniamo l’omologo femminile del sovrano, la “regina”. Il secondo sintagma invece mostra come, mediante l’aggiunta di “nǚ” al sostantivo neutro “háizi” (“bambino”), se ne marchi il genere in maniera inconfondibile, ottenendo una “bambina”[6].
Figura
25: i sintagmi nominali “nǚ wáng” e “nǚ háizi” In tutti questi casi, è bene insistere, non si deve parlare di “caratteri composti”, bensì di unità semantiche, quelle entità distinte graficamente ma unite dal punto di vista del significato, che i Cinesi chiamano “cí”, gli Italiani “parole”, ma che nessuno, a tutt’oggi, sembra in grado di definire con chiarezza. Bibliografia Abbiati, Magda (1992): La lingua cinese, Venezia, Cafoscarina. Abbiati, Magda & Chen, Liansheng (1997): Caratteri cinesi, Venezia, Cafoscarina. Albanese, Andreina (1989): La lingua cinese e le sue principali caratteristiche, Bologna, CLUEB. Eberhard, Wolfram (1999): Dizionario dei simboli cinesi, Roma, Ubaldini. Fazzioli, Edoardo & Chan Mei Ling, Eileen (1998): Caratteri cinesi, Milano, Mondadori. Tan, Huay Peng (1998): What’s in
a Chinese Character, Beijing, New World Press. Viotti Bonfanti, Alessandra (1991): Dizionario cinese-italiano italiano-cinese, Firenze, Le Lettere. Wang, William (1999): La lingua cinese, in Giuseppe Longobardi (a cura di): Le lingue del mondo, Le Scienze quaderni n.108, Milano, Le Scienze. Yuan, Huaqing (1993), La scrittura cinese, Milano, Vallardi. Zhao, Xiuying & Gatti, Franco (1996): Dizionario compatto cinese italiano italiano cinese e conversazioni, Bologna, Zanichelli. Siti Internet
Animated
Chinese Characters
http://www.ocrat.com/ocrat/chargift Consultato il giorno 27 aprile 2001 On-line
Chinese Tools
http://www.mandarintools.com Consultato il giorno 27 aprile 2001 Zhongwenhttp://zhongwen.com Consultato il giorno 27 aprile 2001. Indice
Indice
delle figure
[1] Per tutto il corso del lavoro si è preferito ricorrere ai termini “logogramma” e “logografico” rispetto ai più diffusi “ideogramma” e “ideografico” al fine di evitare ogni possibile ambiguità, dal momento che “ideogramma” è stato adoperato, secondo la terminologia più diffusa tra gli addetti ai lavori, per riferirsi ad un solo tipo di caratteri, distinto da pittogrammi, fonogrammi, etc. Per maggiori dettagli sulla “logografia”, si veda Albanese (1989:26). [2] Gli esempi calligrafici dei diversi periodi storici riportati qui e nei successivi capoversi è tratto da Yuan (1993). [3] I caratteri “nú” (“schiavo”), [4] Occorre però precisare che il dizionario di Viotti Bonfanti riporta separatamente sia i caratteri tradizionali che quelli semplificati corrispondenti, pertanto il numero effettivo di composti che sfruttano questo radicale dovrebbe essere leggermente inferiore. [5] Si è deciso di omettere, in questo caso, il secondo significato del carattere, l’aggettivo “oscuro”, derivato dal primo per metonimia, dal momento che non è rilevante ai fini della presente dissertazione. [6] Quest’ultimo caso, quello di “nǚ háizi”, potrebbe rientrare altresì nella sezione precedente, quella relativa alla discriminazione attuata dalla Cina antica ai danni delle esponenti del gentil sesso. Infatti, qualora il sostantivo “háizi” non contenga alcuna specificazione, sebbene tecnicamente possa riferirsi ad entrambi i sessi, implica di norma che si alluda a bambini, mentre per riferirsi alle bambine è necessario sempre esplicitarne il genere (Eberhard, 1999:40); fino a tempi recenti (1949), le figlie femmine non avevano nemmeno il diritto legale di ereditare ciò che possedeva il padre, e anche per questa ragione le donne in dolce attesa speravano di divenire madri di un maschio piuttosto che di una femmina. |